«Non dissolvermi nei giorni informi del vento / al suolo tornerò non prima / di sapere cosa si annida nelle ossa / quali parole a cui non so dare fiato / chiamano all’altro capo del canto»: con questi versi-preghiera fatti pronunciare al primo uomo Adàm, primogenito del mistero della creazione, si apre Tutte le ossa cantano la canzone d’amore del siciliano Pietro Russo, pubblicato per Pequod nella giovane collana “Portosepolto”.
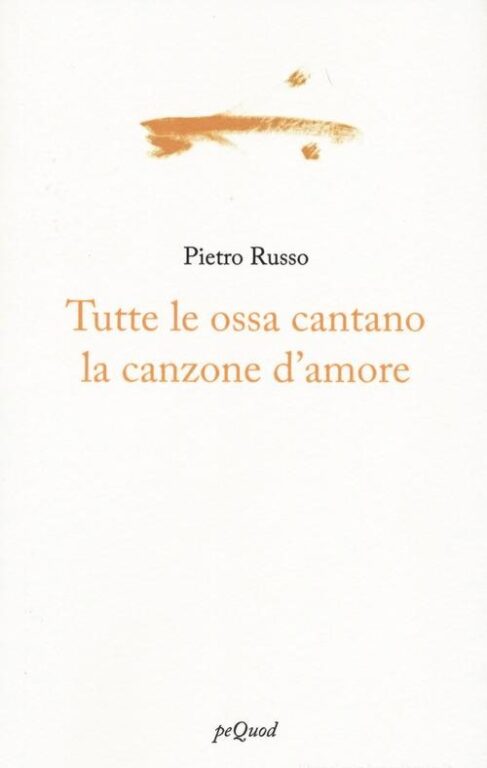
Fin dalle prime pagine ci troviamo davanti ad una discesa simbolica nella caverna in cui Adamo (dall’ebraico אדם “Adam” che deriva da אדמה cioè “adamà”, “terra”) fu tratto dalla rossa materia terrestre e ad una profonda riflessione sulla creaturalità: «C’è un uomo prima di tutto / e io lo chiamo padre / e non vedo la casa costruita / con gli occhi miopi della rinuncia». La miopia di cui Russo ci parla è un possibile riferimento ad un pensiero contemporaneo totalmente deprivato dei suoi fondamenti ontologici di cui invece l’autore si mette inquietamente in ricerca, con gli occhi nuovi di chi sa adottare lo “stupore” come unica forma di resistenza: «Stamattina il mondo si è presentato grigio e gonfio di pioggia / con più forza ho pensato a un’alba che infiamma le case / un’alba d’oceano come vista da un’isola dei tropici».
In quest’orizzonte dove le parole e le cose sembrano ancora poter chiamare e aprirsi al “canto” entrano e prendono nuovamente vita i più disparati frammenti di realtà, che si tratti del rigore fallito di Baggio a Pasadena il 17 luglio 1994, di un’infuocata estate in una svuotata città del Sud tra interminabili rosari e pazienti venditori di kebab, oppure di un viaggio su un treno regionale tra migranti e improvvisi pensieri sulla crudeltà della guerra, che nasce dal cuore dell’uomo tradendone la vera natura di bene:
Viveva in un paese sul mare
ma senza sbocchi sul mare
in un paese dove gli aerei del vicino
radevano i palazzi in segno di forza
e prevaricazione, viveva
un uomo il cui nome non importa
uno che non mischiava le sue ragioni
con le macerie
così chiedeva
alla luce superstite cosa fa di un uomo
un uomo
Chi volesse, sulla scia de Il grande codice di Northrop Frye, studiare gli influssi dei modelli biblici sulla poesia contemporanea, troverebbe in Tutte le ossa cantano la canzone d’amore materiali in abbondanza proprio per la natura originale di questo libro che – in una sorta di moderna e francescana laus creaturarum – rielabora e accoglie al suo interno suggestioni e reminiscenze di quell’opera-mondo che è la Bibbia. Il Libro dei Salmi, le profezie di Isaia, il canto delle ossa risorte di Ezechiele e il mandorlo fiorito di Geremia convivono con le gioiose e tormentate vicende degli uomini, nel “canto” unico di una poesia che – percorrendo una linea “ungarettiana” meno frequentata dalla poesia contemporanea – sa rileggere, proprio come scrisse Ungaretti in Ragioni d’una poesia, “i poeti che cantano”. E il canto di Russo non si limita a quello della tradizione più alta della nostra lingua italiana ma risale fino ai salmi, in una “canzone d’amore” totale in cui convergono sacro e profano, si incontrano e dialogano tradizioni culturali e spirituali diverse e lontane. Come nell’ultima sezione del libro in cui, inaspettatamente, lo sguardo profetico di Geremia incrocia quello dei monaci buddisti che, negli anni Ottanta, giunsero a Comiso per manifestare in modo non violento contro la base missilistica nucleare; una luminosa Pagoda della Pace sorge ora in quei luoghi, in cima ai monti Iblei e al centro del Mediterraneo, per ricordare la bellezza della pace e ciò che ancora “rende l’uomo / un uomo”:
la primavera degli uccelli apre la via
verso eucalipti pini una montagna
sventrata
nam-myoho-renge-kyo
qui, dove esplode il mandorlo
e il sole nella faccia
con la benedizione del vento fratello
fermiamoci a salmodiare
facciamo la casa della lode all’universo.

