Dopo il lucreziano Il moto delle cose uscito nello “Specchio” Mondadori (2017), con La materia del contendere (Garzanti 2025) l’indagine poetica di Giancarlo Pontiggia si spinge ora, sostenuta da un’inquieta vis filosofica, in una sorprendente catabasi nelle profondità della materia, alle origini di un pensiero primigenio che ha qualcosa in comune con la ricerca dell’archè e del logos dei presocratici:
Nel grembo, nell’immoto, nel vuoto
che non è vuoto
materia dopo materia, soffio
dopo soffio, sottile
come la sostanza dell’aria, alto
come un fuoco, che sogna
e si sogna
cima, cielo
non tempo ma oltre
tempo,
spirito che s’infiamma.
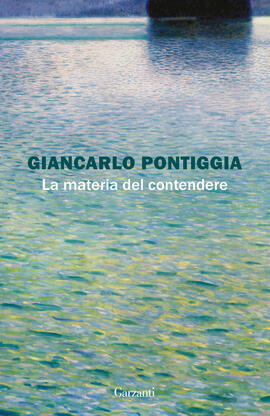
I «semi del vivere» e i frammenti dell’esistenza umana si agitano vorticosamente nel mondo dei quattro elementi (acqua, aria, terra e fuoco) ed è compito del poeta – proprio come un «filosofo che mola le sue lenti, / conficcate / come una selce nel mistero delle cose» – discendere nella complessità del reale mettendosi alla ricerca di una parola remota e originaria, accostarsi a quel fuoco che brucia «vicino / allo spirito delle cose». «C’era, sì, c’era – ma come ritrovarlo / quello spirito nella lingua / quel fuoco nella materia» scriveva Mario Luzi in Per il battesimo dei nostri frammenti, un libro sulle origini della parola che risaliva dal logos giovanneo fino a riflettere sulla frattura tra nome e cosa e sulle possibili mistificazioni e falsificazioni del linguaggio. I versi di Luzi potrebbero forse essere presi in prestito anche per quanto riguarda l’esplorazione condotta da Pontiggia in La materia del contendere, anche se qui ci troviamo di fronte a un territorio molto più accidentato, in una sorta di preistoria e «nel fogliame dei secoli» dove tutto sembra vacillare e sul punto di franare all’istante:
Scorie, lastre,
e tutte
le moltitudini di ori e nomi che popolano
le sabbie della mente
A ogni neve che scende,
vanno giù anche loro
tra i cunicoli di talpa del tempo,
che si dilata in dossi, affioramenti,
cunette,
li invade
un’acquerugiola di sonno, sottile,
che trasmigra
per forre, gore,
camminamenti.
Il movimento eristico e inquieto del pensiero che attraversa La materia del contendere abbraccia la complessità del mondo lasciando grande libertà al flusso immaginativo, in un continuo rincorrersi di figure antitetiche che compaiono nel libro fin dalle prime pagine: «Qualcuno si perderà nell’acqua, qualcuno / nel fuoco. O forse in niente»; «nuotavo, non nuotavo / lungo i banchi di roccia»; «oscilliamo / tra gli specchi del mondo / tra un sì e un no»; «ogni ora è un secolo, e chi passa / non passa mai»; o ancora «tra ciò che somiglia e che non somiglia / è l’opera del mondo», dove si può cogliere forse qualche reminiscenza della luziana “opera del mondo” di Augurio.
Il pensiero poetico di Pontiggia si spinge fin nelle profondità del mondo, ci parla «dal cuore delle pietre» e dai «fossili», da una preistoria che risale fino ai primi segni umani incisi nella materia rupestre, come accade in Lascaux, voce: «Due / che stridono, mugliano / contro il duro di una roccia, / e un albero di morte / su cui oscilla il becco di un uccello». Tutta la «vita del mondo» che brulica in questa babele di frammenti di materia, di pensiero e di lingue è come catturata dall’occhio di chi scrive nell’immagine di «un ranocchio di fiume / al suo primo salto», come se esseri animati e inanimati ritornassero improvvisamente in vita per parlarci dagli albori del tempo. Così accade per un pezzetto di «stoffa, sgargiante di ori e di azzurri», conservata in un cassetto dalla madre e che torna ora a illuminare la memoria «come da un buio di anni», la brocca di Compitalia, 1 che «indugia nel suo cadere, torna / a una tavola di prima», oppure un «basolo» – ossia la lastra di pietra usata già dagli antichi romani per la pavimentazione stradale – che guarda le epoche scorrere impetuosamente sopra di sé:
Sibili, suoni d’ombra, stridi
si agitano in me, come una corrente impetuosa.
Non gli zoccoli dei cavalli
dei legionari, né le sentenze di Appio, né
i piedi sanguinanti di uno schiavo in fuga»
mi scossero
come lo zampettìo di un passero che arrancava,
con un’ala rotta.
«L’animo, quello che chiamiamo umano, / credi di conoscerlo?» chiede al lettore o a sé stesso l’autore di questo magmatico e affascinante libro, in continua ricerca della vita pulsante della materia «che si ferma a un millimetro dal ronzio delle cose / del mondo», in una prospettiva che si potrebbe quasi definire “archeologica” sia nel senso di recupero dell’antichità classica che di ricerca dell’archè da cui tutto deriva, proprio perché c’è «un secolo, dietro ogni secolo. E una rupe / dietro ogni pensiero». Allo stesso modo, in Mezzo futuro ci cade addosso ci ritroviamo a guardare una foglia che «trema, si stacca, verdeggia», in una sorta di anticlimax che esprime bene questa continua risalita verso le origini e verso il mistero dell’essere, come ci mostra la terza persona singolare che occupa interamente lo spazio di un verso: «è / un giorno qualsiasi, / in un posto qualsiasi del tempo, / del vivere / è».
Pontiggia insegue infine gli ultimi pensieri filosofici dell’amato Marco Aurelio, affidando alla voce dell’imperatore romano la cura e la salvaguardia di quella «fedeltà» verso ciò in cui si è creduto e verso la «maestà del pensiero» che ha reso grande la nostra civiltà, come leggiamo nel frammento n. 11: «Quando il tempo viene meno, / e la ragione ci implora: «non interpellarmi più», / quando / nemmeno tu che hai governato il mondo, / puoi più credere in quel mondo, / onora la maestà del pensiero, sii fedele». Ed è forse la stessa instancabile fedeltà a quel «fuoco / che arde» in tutta la poesia di Pontiggia, al non venire meno alle urgenze del cuore: «In un fuoco / in un fuoco che arde, / tra spighe, nel fianco, in un cuore / possente, ferito, dentro / la terra in cui si raccoglie / polvere e polvere di anni / spighe».

