Ne «Il padre sulle spalle» Giorgio Ficara difende la letteratura affrontando uno dei temi più scottanti del nostro tempo: il perpetuarsi di un’organizzazione della società a dominanza maschile[1].
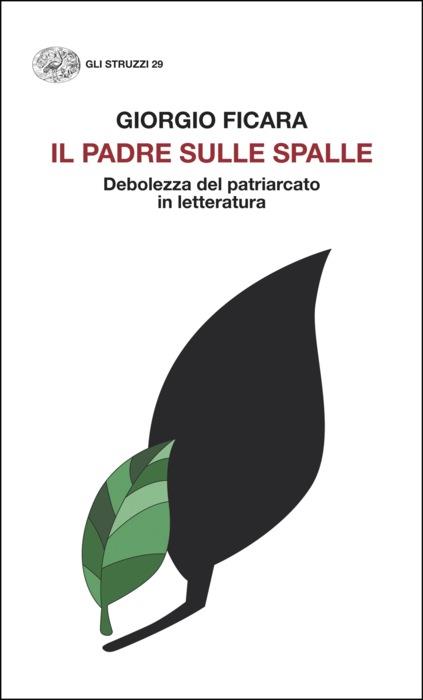
Se il titolo del saggio di Giorgio Ficara sembrerebbe piuttosto rimandare al gruppo marmoreo scolpito da Gian Lorenzo Bernini tra il 1618 e il 1619 e raffigurante la fuga di Enea da Troia in fiamme, è il sottotitolo a centrare il nucleo portante della questione affrontata dall’autore: in un’organizzazione della società, che per secoli si è fondata sulla disparità di genere, in letteratura si può perentoriamente[2] sostenere una «debolezza del patriarcato».
Eppure l’analisi sistematica svolta da Giorgio Ficara sui padri del canone letterario occidentale riferisce di una complessità caratteriale e comportamentale piuttosto ampia. Nella prefazione l’autore spiega come i padri letterari con tendenze «delittuose o nevrotiche» siano tutti rintracciabili e riconoscibili, ma a colpire è ciò che si contraddistingue dal canone. È così a fronteggiarsi – e specchiarsi – sono padri forti “contro” figure più sfocate, indecise e con tendenze malinconiche, da cui viene fuori un nuovo modello paterno a metà strada tra fragilità emotiva e forza dispotica.
«La cifra critica di Ficara è la molteplicità, al limite dell’accumulazione e dell’inventario»[3]: si parte con il poema da cui è tratto il titolo del saggio critico, l’Eneide. Quando sulla spiaggia trapanese Anchise muore, liberando Enea dal peso di trascinare nella sua impresa il padre anziano e stanco, l’eroe protesta domandando perché il padre lo abbandoni proprio in quel momento. Nonostante ora sia sciolto dal macigno e possa finalmente camminare libero, quella stessa libertà spaventa Enea, facendolo sentire solo al mondo.
Se un eroe come Enea, nella sua missione di fondare Roma, può portare avanti la propria responsabilità di protezione nei confronti del padre Anchise e del figlio Ascanio, invece un eroe come Ettore, nell’Iliade, non può. La responsabilità principale di Ettore è verso la patria. Un impegno tale che lo fa desistere anche di fronte alle suppliche di Andromaca di non combattere e di non andare incontro ad una morte certa che gli impedirebbe di vedere il figlioletto Astianatte crescere. Ma per un eroe come Ettore la gloria è l’unica cosa che conta, tanto da sacrificare pensieri “umani” come la preoccupazione di un padre per il bene di un figlio.
Non solo padri consanguinei, ma anche padri “mentori”: per Dante Ficara sceglie Brunetto Latini. E se in molti si sarebbero aspettati forse Virgilio, il critico si sofferma piuttosto sulla capacità di Dante di tornare “figliuol” non appena incontra sulla riva del Flegetonte il notaio fiorentino.
C’è poi un’intera sezione del saggio dedicata ai «senza famiglia»: orfani di padre cresciuti con la responsabilità di cercare la propria strada da soli, ma non per questo costretti unicamente a finali tragici, come nel caso di Renzo Tramaglino. Sempre tra i personaggi dei Promessi Sposi Ficara individua colui che «non ci regge il cuore di dargli il titolo di padre». Si tratta della figura più oscura e malvagia, il peggiore dei padri possibili, personaggio di cui Manzoni non ci rivela neanche il nome: il padre di Gertrude, responsabile della monacazione forzata della figlia e di conseguenza della sua infelicità e di tutti i suoi mali.
Ma non soli padri d’invenzione, Ficara indaga anche figure reali: i padri dei poeti. Monaldo Leopardi nelle lettere al figlio traspare come un padre sentimentale e benigno, quasi materno verso Giacomo. Non come quel padre retrogrado che aveva impedito la fuga del giovane dal borgo di Recanati, quanto piuttosto come un padre sofferente per la lontananza del figlio e che continua a guidarlo attraverso le «amorosissime» lettere. Ma forse è più di tutti Carlo Sbarbaro ad emergere come il padre ideale, il migliore «fra tutti quanti gli uomini». Nonostante appaia «distratto dalla funzione paterna e sprovvisto di precetti e prontuari educativi», ha una dote speciale: è sempre «prontissimo a cedere all’onda umana di fronte alla bellezza e al dolore del mondo. Forse proprio per questo il figlio Camillo riesce a dedicargli una delle poesie più dolci della nostra letteratura:
Padre, se anche tu non fossi il mio
Padre, se anche fossi a me un estraneo.
Per te stesso ugualmente t’amerei.
«Mio padre è stato per me l’assassino» sono questi forse i versi più famosi della nostra letteratura dedicati alla figura paterna. Ugo Edoardo Poli è “colpevole” di essere un uomo senza freni, desideroso di libertà e spensieratezza tanto da conoscere suo figlio Umberto Saba solo quando quest’ultimo ha ormai compiuto vent’anni. Padri odiati dalle madri, padri immaturi che non vogliono sentire il peso della responsabilità genitoriale e padri che se ne vanno, semplicemente perché il flusso della vita impone che, naturalmente, siano i primi a morire. Con Attilio Caproni ritorna la percezione della morte paterna come un viaggio «intrapreso dal padre e non autorizzabile dal figlio» e quindi come Enea diceva: «qui, padre, mi lasci?» Giorgio Caproni echeggia: «perché tu o padre mio la terra / abbandoni?».
Infine, Ficara non si sottrae dallo scandagliare anche il padre con la “p” maiuscola, Dio, il Padre celeste. A questa complicata e intricata vicenda il critico dedica gli ultimi sei capitoli del suo libro, indagando il comportamento a tratti severo e a tratti mansueto di Dio al tempo dei profeti; oppure soffermandosi su Canzoniere 62, nei versi in cui lo stesso Petrarca domanda al Padre del ciel la grazia per vivere un’altra vita.
Credo che ciò che diventiamo dipende da quello che i nostri padri ci insegnano in momenti strani, quando in realtà non stanno cercando di insegnarci. Noi siamo formati da questi piccoli frammenti di saggezza.
(Umberto Eco)
____________________
- G. Pedullà, Letteratura nel nome del padre, “Il Sole 24 Ore”, domenica 20 luglio 1925. È lo stesso giornalista a definire cosa significhi “difendere la letteratura”: «Difendere la letteratura vuol dire amare le storie che non si compongono in una storia unica, lasciarsi incuriosire dai casi irripetibili, rifiutare i paradigmi onnicomprensivi, coltivare lo stupore davanti al nuovo. E vuol dire credere che le avventure e le passioni immaginarie sono importanti per quello che ci fanno vedere del mondo e per come ci fanno vedere qualcos’altro, che prima non c’era, e che senza la letteratura forse non ci sarebbe proprio».
- Ibidem.
- Ibidem.

