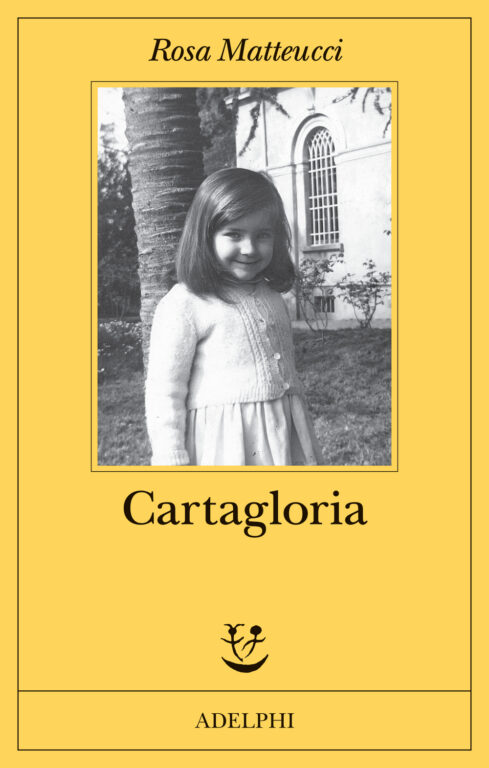
Rosa Matteucci, autrice/protagonista di Cartagloria, era partita per l’India come tanti, in cerca di sé, anche se mettendo nello zaino, al posto del più scontato Siddharta, i libri di Mircea Eliade e René Guénon.
L’esperienza reale dell’India e dell’induismo si doveva rivelare però molto più sfidante di quella letteraria: «i templi sono enormi, bui, grondanti architetture simboliche annerite dal fumo; ovunque un senso di oppressione, di soffoco, la penombra, il crepitare dei fuochi, orde di fedeli che mi spintonavano, l’aria fetida, surriscaldata, l’afrore del sangue delle bestie offerte in sacrificio, la paura di prendere i pidocchi, il timore di inciampare, cadere, di essere schiacciata dal flusso transumante della folla, di finire bruciata viva negli enormi bracieri in cui ardeva la canfora, e certi ometti coperti di cenere con il forcone in cima a uno scalone di mille gradini, e il tempio abitato da scimmie prepotenti e aggressive, e il tempio abitato dai sorci sacri di Durga…» (p. 63).
In occasione del pellegrinaggio oceanico del Maha Kumbh Mela di Allahabad si giunge al parossismo: nella folla innumerevole di pellegrini e di sadhu «molti crollano svenuti, ma non rovinano a terra perché i corpi sono talmente accalcati che si cade sempre in piedi» (p. 65); svenuta a sua volta, l’autrice viene soccorsa e rianimata grazie al miracoloso effetto di un elisir ayurvedico… a base di urina di vacca. «In quel momento ho cominciato a capire l’insensatezza e l’arroganza del mio essere lì. Cosa ci stavo a fare? Come avrei potuto trovare Dio in una religione che mi risultava incomprensibile?» (p. 69).
Il viaggio in India rappresenta un momento saliente nella storia, ampiamente autobiografica, raccontata dalla Matteucci, una scrittrice che si segnala davvero per la finezza dello stile e per un uso sapiente della lingua italiana. Va subito detto che per tutto il libro i toni oscillano tra il tragico e il comico, non si tratta però del solito cinismo tanto di moda in questi tempi di compiaciuta disperazione, ma di una forma di autoironia che permette di cogliere il comico nelle più diverse esperienze della vita, tragedia compresa, senza che con ciò il dolore venga meno. Nata nei pressi di Orvieto, l’autrice/protagonista vive da bambina il drammatico tracollo della sua famiglia, un tempo facoltosa e rispettata e ora caduta in uno stato di profonda abiezione. L’apice della catastrofe sopraggiunge proprio nel momento in cui la bambina dovrebbe prepararsi a ricevere la prima Comunione, ma lo stato quasi allucinato di tutti i suoi familiari fa sì che nessuno se ne occupi. Il padre, folle dissipatore del patrimonio familiare, eppure sinceramente amato; la madre, donna di straordinaria bellezza, ma alquanto anaffettiva; i nonni, come spaesati davanti a ciò che sta accadendo: tutti sembrano sotto l’effetto di un sortilegio, avviluppati dalla maledizione che si abbatte sulla loro casa e, di conseguenza, non tengono in minima considerazione il desiderio della bimba di potersi accostare alla prima Comunione come tutti i suoi coetanei. Da qui un senso di esclusione, marginalità, inadeguatezza che avrebbe accompagnato la protagonista nell’età adulta – «non mi voleva mai nessuno, per me non c’era posto da nessuna parte» (p. 57) – ma allo stesso tempo una tensione verso la trascendenza, un anelito al sacro inestinguibile, quasi doloroso, a lungo inappagato.
Negli anni seguenti la protagonista vive le esperienze spirituali più disparate: dall’India, al buddismo della Soka Gakkai, alla frequentazione di quelle che si rivelano due laide fattucchiere – che le propongono, tra l’altro, di sottoporsi a riti sciamanici celebrati da un guaritore andino all’interno di un ristorante vegano (nel giorno di chiusura, con spuntino compreso nel prezzo). Mentre si svolge questa difficile ricerca interiore, hanno luogo alcune svolte cruciali nella vita della protagonista, una delle quali è l’improvvisa morte del padre. Anche in questo caso, viene lasciato spazio a dettagli grotteschi, che tuttavia non cancellano il trauma della separazione: il giorno del funerale, dopo il lento e solenne corteo al seguito della berlina delle pompe funebri, all’arrivo al cimitero si rende manifesto «il deplorevole scambio di defunto, non essendo il detto camposanto sede dell’avita cappella di famiglia, bensì una necropoli altra, dove non vantavamo nessuna conoscenza degli estinti colà tumulati». Come se non bastasse, una volta raggiunta, con qualche affanno, la cappella di famiglia nel cimitero corretto, si scopre che la tumulazione è impossibile, dal momento che tutti i loculi sono occupati: «da donna pratica, mia madre suggerì di effettuarla in un angusto canto a destra dell’altare, posizionando la bara in verticale così come gli Egizi usavano con i sarcofagi delle mummie, suggestiva ipotesi alla quale mi opposi con fermezza» (p. 78).
In seguito alla morte del padre avrà luogo il pellegrinaggio a Lourdes, narrato dalla Matteucci nel suo romanzo d’esordio (intitolato appunto Lourdes e apparso nel 1998 sempre in Adelphi), che la condurrà, pur controvoglia e insofferente, a una straordinaria esperienza mistica.
Giunta quasi per disperazione ad andare regolarmente a messa, l’autrice si scontra con il grigiore e la prosaicità del rito nato dalla riforma liturgica seguita al Concilio Vaticano II e si accorge che, per motivi molteplici, non fa proprio per lei. A quel punto non rimane, extrema ratio, che la ricerca di una chiesa dove venga celebrata la liturgia nel rito romano tradizionale. La ricerca non è cosa da nulla; ora però la scrittrice vive a Genova e, con un po’ di pazienza, può trovare la “messa di sempre” prima a Lavagna e poi nella chiesa abbaziale di Santo Stefano, nel centro di Genova. Si tratta di un punto d’arrivo, alla fine di un cammino tormentato, e al contempo di un nuovo inizio, non facile. Ancora una volta un ambiente sconosciuto nel quale si sente estranea e inadeguata, ma insieme la nuova certezza «di aver assistito a una celebrazione della Verità nel senso più profondo e inafferrabile della parola» (p. 125); col passare delle settimane, la “messa in latino” comincia a disvelarsi «nella sua prodigiosa sacralità, nella sua ricchezza di trascendenza, nella sua divina grazia donata con amore indescrivibile tramite parole umane» (p. 129). Le onde del mare in tempesta l’hanno miracolosamente portata in un luogo nel quale «l’anima riceve nutrimento e luce».
L’approdo alla liturgia tradizionale non rappresenta per la Matteucci un fugace momento di crisi mistica, ma, come ella stessa ha avuto occasione di osservare, è il compimento di una faticosa e consapevole ricerca di Dio avviata fin dall’infanzia, in un anelito verso la trascendenza che deve necessariamente portare a un vero atto di fede, se si vuole che il cammino compiuto abbia significato. Cosa che non è certo facile nel clima di apostasia e “morte di Dio” che avvelena la nostra società, nella quale dirsi cristiani è divenuto un atto di autentica trasgressione. L’itinerario spirituale (e insieme l’elaborazione dei tanti lutti) della protagonista/autrice si compie nell’intuizione liberante del significato conferito a tutta la nostra esistenza da Cristo crocefisso: all’uomo tocca portare la sua croce, «perché alla fine croce e libertà sono la stessa cosa» (p. 151).

