«Difende la sua riserva d’acqua / che è il bene più prezioso / nel deserto / come altrove il denaro. / Attenti a rispettare la soglia, / non sono fragili le spine»: sono versi del poeta Giampiero Neri[1] – quasi un’epigrafe o l’apparentemente semplice didascalia di una specie botanica resistente ai climi aridi – che leggiamo in Armi e mestieri, pubblicato nel 2004 per lo Specchio mondadoriano e recentemente riproposto da Ares con un’introduzione di Roberto Galaverni. Versi che, nella loro esatta trasparenza, sono già indicativi dell’arte del levare che caratterizza la poesia di Neri, di quel non detto che emerge dalla descrizione di figure o situazioni a prima vista elementari e ordinarie. Sono in realtà significati profondi, indizi di un’altra «posta in gioco» che si nascondono, in un vero e proprio procedimento di mise en abyme, nella scrittura di Neri:
Delle figure e dei fregi
si osservano sulle ali delle farfalle
e in altre specie diverse
ornamento e difesa insieme,
simili a cerchi e disegni
detti anche macchie ocellari,
sono una varietà di mimetismo
l’immaginario occhio di Dio che guarda
Con l’immagine di uno «stormo di uccelli» che si abbatte «vociante / sui rami di un albero / come a un traguardo» si apre Armi e mestieri e il poeta ci avverte fin dall’inizio che «era un’altra la posta in gioco, / a dirigere il volo impetuoso». Non è dato al lettore conoscere ulteriori dettagli di questa scena, un senso ulteriore sembra premere e sconfinare dall’immagine, metterci come in allarme. Nella sua introduzione ad Armi e mestieri Galaverni individua i tratti peculiari di questa maniera di Neri di guardare la vita e il mondo attraverso la scrittura:
È il non detto in Neri che più si fa sentire, è il fuori campo quello che più viene messo a fuoco. E i suoi lettori sanno bene di cosa si tratti, vale a dire di come l’aggressività, la violenza, l’efferatezza, la colpa, la paura e, soprattutto, il sospetto dell’indecifrabilità ultima dell’agire dell’uomo (un senso e una giustizia che potrebbero non venire mai), siano parte integrante della visione della realtà sottesa all’apparente pacatezza del dire, si tratti della manzoniana storia, si tratti invece della leopardiana natura.
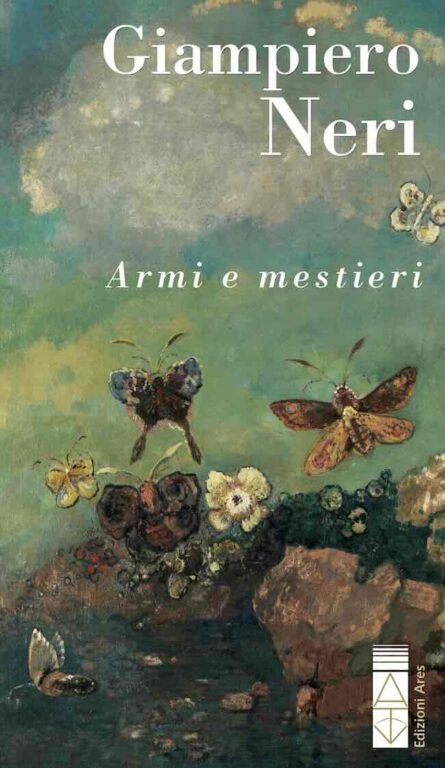
Si tratta di un vero e proprio «punto di vista» con cui lo scrittore, con la consueta intelligenza e lucida razionalità che lo contraddistingue, osserva come un pittore alle prese con la tela i dettagli del mondo che si concretizzano nel campo visivo: «Alla ricerca di un punto di vista / l’apprendista pittore si era inerpicato / su un dosso scosceso del parco, / si misurava col lago in lontananza / che dimorava placido / nell’aria azzurrina».
Per comprendere a pieno la ricerca di Neri, finissimo osservatore dei fenomeni umani e naturali del mondo, è utile rileggere l’autoritratto che il poeta stesso delinea nelle prose poetiche de Il professor Fumagalli e altre figure: «un moralismo di marca lombarda, che farei coincidere con una sorta di accettazione degli avvenimenti, destino difficilmente modificabile dagli sforzi umani […]. Sono spesso ricorso a figure di animali, nostri compagni di viaggio. Costretti come sono ad agire allo scoperto, gli animali permettono a chi li studia una osservazione realistica»[2].
Osservazione dunque mimetica, attraverso i numerosi animali che compaiono nelle pagine di Armi e mestieri (uccelli, vitelli, farfalle, ghiri, pesci, civette) o piante (kiwi, betulle, sempreverdi, opunzie) che consente al poeta di sondare meglio in profondità alcuni temi decisivi per la sua poesia. Tra questi, la riflessione sull’enigma del male nella storia, come ha avuto modo di osservare sul “Domenicale” Daniela Marcheschi («La sua poesia si staglia come una sorta di angelo sterminatore dell’oblio, vittima della Storia-carnefice del Tempo ed è concentrica e ciclica») mettendone in rilievo la centralità nell’opera neriana: «L’assillo del Male: quello della Morte, del Destino che sorprende e scompagina le attese. Che si mimetizza per trafiggerci e porci davanti a noi stessi senza modo di barare»[3].
Accanto ai mestieri che accompagnano e ritmano il trascorrere dell’esistenza umana, le armi sono simbolo di quella violenza della storia che torna costantemente nell’opera di Neri:
Armi e mestieri è un titolo importante per me, perché si rifà al motivo per cui io scrivo; e cioè alla presenza di questa conflittualità vitale. Anche perché io sono segnato dalla violenza, che da una parte mi attrae e dall’altra mi fa vedere il suo aspetto orrido. Su di me agiscono entrambe queste cose […] Il polemos è la legge più importante della vita. Quindi Armi e mestieri è per me importante per questo. In fondo può essere una parafrasi di Guerra e pace di Tolstoj. Ma a me è venuto in mente semplicemente per una deformazione del titolo ‘Arti e mestieri’. I mestieri sono le attività che si fanno in tempi di pace, per vivere. Anche se pure la guerra si fa per vivere[4].
Così la lotta presente nel dinamismo esistenziale e nel cuore dell’uomo è rintracciabile anche nel mondo animale e vegetale, nascosta in molteplici e misteriose forme. E Neri, con lo stupore di un naturalista o di un saggio incline al silenzio, sa avvicinarci ancora una volta alla loro vita segreta:
Da quali nemici si difende
la rivestita di spine?
è tenace la memoria delle piante
non abbassa la guardia.
Se torneranno le specie a loro avverse
le troveranno pronte, ad aspettarle»
___________________
- Di Giampiero Neri (1927-2023) – pseudonimo di Giampietro Pontiggia, fratello maggiore del romanziere Giuseppe Pontiggia – la Biblioteca della sede di Milano dell’Università Cattolica custodisce il fondo archivistico e librario. Per una prima ricognizione della biblioteca di Neri si rimanda a: M. Mandorlo, Giampiero Neri: un primo sguardo alla biblioteca del “maestro in ombra” / 1, Cattolica Library, 51, 2023 e a M. Mandorlo, Giampiero Neri: un primo sguardo alla biblioteca del “maestro in ombra” / 2, Cattolica Library, 52, 2023.
- G. Neri, Il professor Fumagalli e altre figure, Mondadori, 2012, p. 94.
- D. Marcheschi, L’enigma del male nella storia, “Il Sole 24 Ore”, domenica 23 marzo 2025.
- E. Abate, Due conversazioni con Giampiero Neri, “Poliscritture”, aprile 2005, p. 44.

